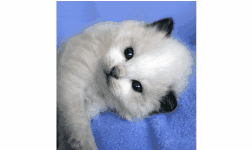IL DOLORE DELL'UOMO E IL SILENZIO DI DIO
Desidero rinnovare questo articolo scritto con una problematica tanto discussa dalla politica e dalla religione. L’occasione mi viene data da un post di Fra Benito pubblicato su FB:
".. oggi ricordo Eluana .. e il suo papà Peppino .. e tutti coloro che della loro situazione drammaticamente sofferente hanno vissuto, e vivono, rumori inutili anziché silenzi indispensabili .. il loro è stato un grido sfinito come quello di Giobbe .. e noi siamo per loro solo dei "medici del nulla" .. perché l'urlo di reazione di chi sta male è sempre un grido di lotta e di resistenza a ciò che avviene coscientemente o incoscientemente alla propria vita ferità .. e al grido del dolore innocente che vuole spegnere la vita non ci sono risposte uguali e precise, neanche quelle che ci sembrano di Dio .. il quale pone 'il suo primo sguardo sempre sulla sofferenza delle persone, e non sul loro presunto peccato' .." (Fra Benito)
Il percorso di accettazione

Vivo in questi giorni una condizione di infermità che unita a quella del mio sposo mi ha portato a fare alcune riflessioni che desidero condividere con tutti voi cari amici del web.
Chi si scopre malato intraprende un cammino difficile e impervio per prendere atto della propria situazione e conviverci. La speranza a volte porta a cercare strade faticose e a volte impreviste, tortuose e poco sicure, ma chi può sapere a cosa porta la nostra corporeità? A volte, quando ti senti più sicuro, giungi a conoscere una diagnosi che conduce a niente di buono.
Scrivo quest’articolo sulla spinta, che con molta sensatezza si prefigge lo scopo di chiarire quanto realmente può succedere e si può pensare, in qualsiasi contesto, da giovani o anziani, da abbienti o indigenti ci si trovi a vivere (guardiamo il nostro amico Cassano… che Dio ce lo ridia presto guarito!). Ricevere una diagnosi sfavorevole impone all’individuo una strada che può deviare o interrompersi in alcune tappe. Chi si ammala si vede quasi all’improvviso scaraventato al di là di una sorta di confine del quale non conosceva neppure l’esistenza, ossia il confine tra chi è sano e chi non lo è.
UN ALTRO MONDO – Questo confine è fatto soprattutto di una dolorosa incomunicabilità fra le persone che si trovano ai due lati. Chi sta vicino ad una persona affetta da una patologia seria non è in grado di capire fino in fondo ciò che succede nel proprio familiare, amico, compagno di vita e spesso non riesce neppure ad attivare un atteggiamento di sereno ascolto, che possa permettere a chi si ammala di esprimere le proprie emozioni e paure o, se preferisce, parlare di cose leggere per distrarre l’attenzione. Chi fa l’esperienza di una malattia seria entra concretamente e irrimediabilmente in contatto con la propria fragilità e con la prospettiva della morte. A quel punto la vita diventa da quel momento in poi un percorso a tappe, fatte di speranze, visite specialistiche, esami, indagini strumentali, disillusioni, paure, nuove speranze, terapie, effetti collaterali delle terapie. E poi di nuovo esami, controlli, valutazioni, altre terapie.
UNA DIFFICILE ACCETTAZIONE – Se la malattia è cronica ma non mortale, la persona colpita ha bisogno di trovare un equilibrio che preveda l’accogliere la malattia stessa e inglobarla nella propria quotidianità. Per questo essere portatori di una malattia cronica significa sostanzialmente rivoluzionare la propria vita perché essa sia il più possibile protetta dagli effetti della malattia stessa. Nel caso delle malattie mortali o potenzialmente tali, comunque delle malattie progressive, si deve fare i conti con la finitezza della vita umana, con la paura della morte e soprattutto di come e quando essa possa avvenire. Si possono passare momenti di angoscia intensa, assolutamente non comunicabili, talvolta minimizzati dai propri cari che cercano di non affrontare, loro per primi, l’angoscia legata alla sofferenza a cui devono assistere.

La morte dolce
Impossibilitata a recarmi quotidianamente dal mio sposo reso ormai un Cristo, senza più fattezze umane, consunto dalla sofferenza e allo stremo delle forze, mi sono chiesta quanto abbia contribuito l’assisterlo ogni giorno per questi lunghi anni nel ritrovarmi in questo mio stato e se sia giusto che una famiglia precipiti in un abisso così profondo per chi soffre e per chi assiste.
Ricordo che tempo fa, nello stato di Washington fu indetto un referendum per legittimare l’eutanasia, ma nonostante fossero molti i convinti sostenitori della legittimazione del “suicidio assistito” la maggioranza dei cittadini (il 55%) ha detto no a tale forma di intervento sull’esistenza umana. Ebbene anch’io mi sono chiesta se sia giusto o meno, in democrazia, e secondo coscienza, chiamare gli elettori a pronunciarsi sulla vita o sulla morte, sulla salute o sulla sofferenza, sull’accettazione della propria con dizione esistenziale o sulla «buona morte», al fine di non dover sostenere una lotta per sopravvivere.
Ho letto varie opinioni, di medici, di studiosi, di gente comune, laici e cattolici, ne ho ricavato la convinzione che la maggioranza degli italiani è contraria ad un referendum che decida della vita degli altri. E poi, una volta che l'eutanasia fosse approvata e ammessa dalla legge, chi ci garantirebbe dagli abusi?
Infatti potrebbe diventare un facile mezzo per liberarsi di persone anziane «scomode», di handicappati e malati cronici, di giovani drogati o affetti da AIDS che si sentono soli e abbandonati.
Sarebbe giusto tutto questo?
È terribile pensare che una legge possa disporre della vita di mio marito ancora cosciente, di una persona qualsiasi sia pure al limite della vita e che una maggioranza possa legittimare che vi sia un medico o un familiare, il quale sia disponibile ad assecondare una violenza, una offesa fatta alla volontà della «non sofferenza».
Una cosa è cercare il consenso nel curare il dolore, nel lenire le sofferenze, un'altra cosa è dare un senso diverso all'esistenza, magari qualificandosi maggiormente come «atto d'amore».
Si è giunti addirittura a consegnare «una bustina» al paziente che lo chiede se colpito da una malattia inguaribile, affinché possa bere qualche cosa che lo faccia morire in pochi minuti.
Questo accade in Olanda, dove a pochi chilometri da Amsterdam c'è un ospedale moderno, che consente di praticare l'eutanasia senza distinzione di età, perché la «morte dolce» trovi spazio e liberi il mondo da gente ormai inutile.
Il medico che assiste gli ammalati a Casa Madre Teresa quando ho chiesto se sia giusto vederli soffrire così, intubati, alimentati artificialmente, totalmente paralizzati, ciechi, muti … mi ha risposto che mai e poi mai un’etica professionale permetterebbe loro di abbandonarli fino all’ultimo respiro.
“Questa è la vita” mi disse Mentore quando entrammo come “ospiti” ed è così!

Quanto vale la vita?
Se «soffrire non è un modo degno di vivere», vuol dire che la vita è qualitativamente valida soltanto nelle migliori condizioni di salute e di benessere, altrimenti è inutile assistere, sacrificarsi, essere generosi verso gli altri: è una perdita di tempo, una spesa eccessiva senza risultati tangibili.
Stiamo attenti che, se si fa strada una simile convinzione, è facile ampliare lo spazio per affrettare il trapasso di tanti infelici, ai quali in questo modo si nega il diritto di lottare per prolungare l'esistenza e per avere vicino qualcuno che mostra affetto nei momenti peggiori.
Non mi sembra che, dal punto di vista morale e religioso, vi sia una giustificazione accettabile a procurare la morte a chi la chiede o a chi crede di poter finire di penare affrettando il trapasso.
Con l'eutanasia ci troveremmo a dover sostenere meno spese e minori difficoltà assistenziali, ma avremmo tanti problemi affettivi e psicologici da risolvere, che aumenterebbero le difficoltà per coloro che devono prendere decisioni vitali per gli altri.
Non è più conveniente dare impulso allo studio, alla ricerca, alla migliore convivenza ambientale piuttosto che fabbricare strumenti di morte?
Quei bambini, quegli adulti, quegli anziani che, in tante parti del mondo sottosviluppato o industrializzato, muoiono ogni giorno senza cibo, medicine, cure, assistenza non rappresentano già una forma di eutanasia indirettamente voluta da coloro che stanno meglio e hanno per sé la maggior parte dei beni materiali e degli affetti?
Perché, dunque, voler legittimare «un genocidio» che avviene quotidianamente senza che neppure ce ne accorgiamo?
Perché non reagire e sentirsi in colpa, cercando di dare un senso migliore alla vita, specialmente di tanti, piccoli e grandi, che non possono beneficiare di alcuna felicità?
Vorrei che le mie modeste considerazioni fossero condivise da qualcuno di buona volontà, che cominciasse a reagire efficacemente per dare al nostro sistema democratico un carattere meno liberticida e più coscienzioso verso problematiche che devono puntare alla libertà, ma con un senso di grande responsabilità.
E da ultimo, con coscienza religiosa vorrei come il piccolo fratel Carlo abbandonarmi al Padre perché faccia di noi quanto di meglio crede … lui sa ciò che è bene … perché è solo AMORE!
La preghiera dell’abbandono
Padre mio,
Io mi abbandono a te:
fa’ di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto,
accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima
nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore
il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani
senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché tu sei il Padre mio.
















.jpg)
 Quando il corpo ritrova le proprie frequenze armoniose, ritrova la salute ed il benessere. Le Campane Tibetane producono suoni in armonia con le vibrazioni cosmiche risvegliando e rimembrando qualcosa che c’è già dentro all’essere umano. Solo che è molto in profondità e lo spesso strato che si è accumulato in superficie non ha fatto altro che allontanarsi da quel suono originale portando uno stato di “non accordatura”, quindi stonatura e dissonanza. Le vibrazioni delle campane tibetane dunque accordano e sintonizzano l’individuo nell’orchestra sinfonica del cosmo sostenendo una condizione di prolungato benessere.
Quando il corpo ritrova le proprie frequenze armoniose, ritrova la salute ed il benessere. Le Campane Tibetane producono suoni in armonia con le vibrazioni cosmiche risvegliando e rimembrando qualcosa che c’è già dentro all’essere umano. Solo che è molto in profondità e lo spesso strato che si è accumulato in superficie non ha fatto altro che allontanarsi da quel suono originale portando uno stato di “non accordatura”, quindi stonatura e dissonanza. Le vibrazioni delle campane tibetane dunque accordano e sintonizzano l’individuo nell’orchestra sinfonica del cosmo sostenendo una condizione di prolungato benessere.