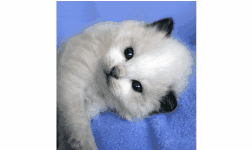Sul filo

(Matteo 4,12-23)
III^ Tempo Ordinario
Neanche un versetto e tutta la storia di Giovanni Battista si arresta, si ferma. Il grande profeta è ridotto a notizia che arriva a Gesù, un filo commosso di voce: Giovanni è stato arrestato. Giovanni è stato consegnato al potere, alla banalità del male, alla stupidità degli esseri umani. Il deserto è chiuso in gabbia, la voce zittita, il fiume non scorre più. Gesù non dice nulla, ascolta e cammina, disegna sulla mappa una curva inaspettata e decide di raccogliere definitivamente l’eredità. Secondo qualcuno questo è il momento in cui lo stile della predicazione cambia, la durezza di Giovanni lascia il posto alla misericordia del Messia. Probabilmente è vero ma io credo che ci sia anche, nel silenzio commosso di Gesù, la coscienza di essere chiamato a raccogliere una fedeltà alla vita che Gesù riconosce al profeta. Perché Giovanni ha accettato di perdere tutto, perché Giovanni morirà per giochi perversi di potere, perché Giovanni è spogliato e solo. Perché Giovanni è consegnato e sceglie di andare fino in fondo. Perché è quando non hai più niente che puoi dare tutto. Quando sei davvero povero, quando non sei più il profeta acclamato, o il rivoluzionario temuto, quando hai perso è allora che puoi dare la vita. Gesù vede e si riconosce e decide.
Gesù raccoglie questa vita consegnata e inizia a consegnare definitivamente la sua. Cominciando da lontano, dalla Galilea, luogo di frontiera, regione dove le fedi e le culture si intrecciano, dove la religione è libera dalla sterilità camuffata da perfezione del Tempio. Luogo sporcato dalla vita, luogo che espone a tutte le incomprensioni possibili, luogo vivo e fertile, luogo complesso e difficile da decifrare, luogo ventre di tutte le fami del mondo, luogo incoerente e immaturo, regione in cui si è minoranza tra le minoranze: Gesù parte da lì. E a me commuove che la Galilea sia molto simile a questo nostro mondo postmoderno che come comunità cristiana continuiamo a criticare.
Gesù sceglie il confine e nella terra di confine decide di camminare la soglia: tra terra e mare, come a seguire un filo teso sopra l’Abisso, come a dire che la vita la assumi esponendoti al rischio di perderti: tra terra e mare, luce e tenebre, vita e morte. Cammina Gesù, funambolo dell’Infinito, e da quella nuova prospettiva fa scivolare verso l’umanità il suo sguardo profondo. Sguardo di chi conosce le tenebre del cuore e non le condanna, sguardo di chi è abitato dalla Luce ma non la impone. Forse i primi discepoli si sono fidati di Gesù perché in quello sguardo hanno sentito Gesù camminare anche dentro le loro di storie, da funambolo, con leggerezza e grazia. Perché ogni uomo è terra di confine: luce e tenebre, vita e morte, Gesù camminando con grazia e leggerezza ha guardato con amore dentro le tenebre dell’uomo e ha saputo proporre una fune tesa da iniziare a camminare. Stavano gettando le reti Simone e Andrea e sempre le avrebbero lanciate, giorno dopo giorno, di sopravvivenza in sopravvivenza ma quel senso di vita che non basta, quel senso di vuoto che nausea, quel bisogno di dare un senso ultimo alla propria storia, quello le reti non lo scalfiscono. La pesca permette alla vita di sporgersi un giorno ancora sul tempo ma il senso di tutto questo? E quando ti fermi a riparare le tue reti, quelle che portano addosso le ferite inevitabili del quotidiano quando, come Giacomo e Giovanni, ti ritrovi a tenere insieme una vita che continuamente ha solo bisogno di essere riparata e anche questo, lo sai, in una ripetizione senza fine… se incroci uno sguardo che ti accompagna a scendere dentro l’abisso che ti porti dentro tu le reti le lasci e anche il padre e le barche. Non perché vuoi fuggire ma perché hai sentito distintamente la possibilità di poter cominciare a desiderare la vita. Quello che ti porta a camminare in equilibrio tra la vita e la morte, quello che ti espone al rischio di perderti o a quello di trovarti è la scoperta di una promessa nascosta dentro lo spazio e il tempo che ti è stato chiesto di abitare. Gesù, funambolo della vita, con uno sguardo, ha promesso ai suoi un cammino per uscire dalle tenebre che ognuno si porta dentro. Cammino dal prezzo altissimo, cammino di tutto o niente: perdere la vita per trovarla. Si inizia lasciando le reti e si finisce lasciando la vita: solo ed esclusivamente per trovarsi. Per arrivare finalmente a guardarsi come Dio ci guarda. Gli occhi di Gesù sono inizio e compimento.
Camminano dietro di lui i discepoli, su quel filo teso tra vita e morte, tra mare e deserto, profumo di Esodo e libertà. Dietro di lui, pronti a cadere per lasciarsi rialzare. Nessuna preparazione previa, nessuna annunciazione, nessuna nascita verginale, nessun angelo per loro a schiodarli dal quotidiano: solo un uomo che ha guardato le tenebre del cuore con grazia e senza condanna.
Un uomo che parlava di conversione e di un Regno vicino. La conversione erano quegli occhi profondi e misericordiosi, se lo seguivi era perché quegli occhi ti avevano incantato, che il desiderio di vita si risveglia solo se occhi luminosi ti toccano le corde del cuore, se senti misericordia invaderti, se ti senti amato, il resto viene dopo. Conversione è cambiare lo sguardo, il proprio sguardo sui fratelli. E in quegli occhi sentire che il Regno è presente, adesso. Non un paradiso terreste lasciato alle spalle e nemmeno un paradiso celeste appeso alla speranza, no, se ti senti guardato da Lui tu senti che quello è lo sguardo di Dio, che Dio ti ama così, adesso, e le tenebre del cuore non spariscono però non ti fanno più così paura. Quantomeno smetti di nasconderle. Dentro uno sguardo così potevi perfino piangere. Per questo lo seguirono.
“Pescatori di uomini”, non era chiara quella promessa. Si intuiva che non erano chiamati a diventare altro, che dovevano continuare a essere loro stessi, pescatori, che la storia non si cancella ma si prende tutta, per quello che è e per quello che è stata solo c’era urgenza di una nuova attenzione all’uomo. Dovevano imparare quello sguardo. Quello sguardo che li aveva conquistati e sedotti sarebbe dovuto entrare anche nei loro occhi. Gesù stava pescando uomini, stava pescando loro. Stava trascinando fuori dalle acque ferme e tenebrose della vita un gruppo di uomini perché anche loro, un giorno, fossero capaci di sguardi luminosi e profondi, di cammini funambolici sopra l’abisso, di consegna totale di sé. Il Vangelo di oggi è la descrizione dei primi passi sulla fune tesa che porta alla vita. La pagina di oggi è pagina da rileggere ogni volta che cadiamo e perdiamo il desiderio. Ogni volta che i nostri occhi si spengono e diventano increduli e si accontentano di riparare reti. Ogni volta che ci dimentichiamo come ci guarda Dio.